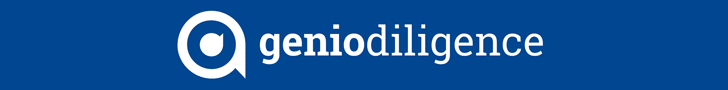24 Febbraio 2026 / 20:54
Trend topics
L'IA Agentica è la nuova frontiera della trasformazione aziendale. La tecnologia è già pronta; ora colmare il divario di competenze, rafforzare la formazione e favorire una regolamentazione chiara e abilitante sono i passaggi imprescindibili per non perdere il treno, e per trasformare la promessa dell'IA in produttività reale. I risultati dell'analisi dell'AI Skills 4 Agents Observatory promosso da The European House - Ambrosetti insieme a Microsoft.
Mentre ancora individui e aziende si stanno orientando per comprendere potenzialità e limiti dell'IA Generativa, ecco che una nuova trasformazione sta cominciando a entrare nei processi e nei servizi delle imprese. Stiamo parlando degli AI Agents, o IA Agentica, sistemi intelligenti capaci di agire in autonomia, prendere decisioni e adattarsi a contesti complessi. Una trasformazione che, secondo il nuovo Rapporto elaborato da The European House - Ambrosetti insieme a Microsoft, come frutto del lavoro svolto dall'AI Skills 4 Agents Observatory, segna un vero spartiacque per la competitività dei Paesi e delle imprese.

Una geografia guidata dagli investimenti
Il primo dato che emerge con forza dal Rapporto, presentato a Cernobbio in occasione dell'ultimo Forum THEA - The European House Ambrosetti, è la polarizzazione del mercato globale dell'IA. Nel 2024 gli Stati Uniti hanno assorbito il 72,4% degli investimenti mondiali, confermandosi attore dominante, seguiti a distanza dalla Cina con poco più del 6%. L'Europa segna il passo: Francia e Germania hanno volumi tripli rispetto all'Italia, che si colloca solo al quindicesimo posto. Questo divario non è solo numerico, ma strategico, sottolineano i ricercatori: controllare modelli, dati e infrastrutture significa anche dettare gli standard di riferimento per l'intera economia digitale.
Un indicatore significativo è l'AI Index, che raccoglie 15 aziende internazionali con core business nell'intelligenza artificiale. Tra il 2018 e il 2025 ha registrato una crescita del 614%, a fronte del +210% del Nasdaq: segnale che il comparto non è più un segmento di nicchia, ma il vero motore trainante della finanza globale. A questo si aggiunge l'impennata dei finanziamenti da venture capital e private equity, con un incremento di 2,5 volte tra il 2020 e il 2024 e una concentrazione crescente nei mega-round oltre i 100 milioni di dollari. OpenAI, Anthropic, Databricks e xAI da sole hanno raccolto oltre 32 miliardi, accentuando il vantaggio competitivo delle big tech statunitensi.
L'impatto sull'economia europea e italiana
Sul piano macroeconomico, il modello sviluppato da TEHA stima che l'IA potrebbe far crescere il PIL europeo fino al +15,2% annuo, pari a 2,6 trilioni di euro, cioè l'equivalente del PIL della Francia. Per l'Italia il potenziale è ancora più significativo: un incremento massimo teorico del +17,9%, pari a 336 miliardi di euro ogni anno, cioè più dell'intero PIL della Repubblica Ceca.
L'effetto non sarà uniforme: i settori a più alta intensità cognitiva e digitale, come i servizi finanziari e l'ICT, potrebbero superare il +25% di crescita in termini di produttività. Anche comparti più tradizionali, come l'agricoltura o l'estrazione mineraria, mostrano comunque guadagni superiori al 13%. L'elemento chiave non è tanto la natura del settore, quanto la capacità di integrare processi intelligenti in modo trasversale.
E la vera sfida è quella di trasformare questo guadagno di efficienza in nuova occupazione qualificata, coltivando da subito nuove skills a tutti i livelli, tanto nel mondo della formazione scolastica e universitaria, quanto all'interno delle aziende stesse.
Possibilità e limiti dello scenario italiano
Il tessuto imprenditoriale italiano sta compiendo passi avanti significativi. La quota di aziende che utilizza l'IA è passata dal 51% nel 2023 all'84,7% nel 2024, e nessuna impresa dichiara di voler restare esclusa in futuro. I benefici percepiti vanno dall'aumento di efficienza e produttività (83% delle imprese) alla personalizzazione dell'offerta per i clienti, fino a un maggiore supporto all'innovazione.
Tuttavia, emergono tre grandi ostacoli: la carenza di competenze interne, le incertezze normative e la resistenza culturale al cambiamento. Se nel 2023 il principale freno era la mancanza di skill, nel 2024 in testa si collocano i timori di compliance e regolamentazione, segno che l'attenzione delle aziende si sta spostando dal "cosa" al "come" adottare la tecnologia. Una quota significativa di imprese indica anche il dubbio sul ritorno dell'investimento, alimentato dall'assenza di metriche condivise e dalla difficoltà di stimare l'impatto economico nel medio periodo.
Un ulteriore fattore critico riguarda l'etica e la tutela dei diritti individuali: privacy, bias e trasparenza degli algoritmi sono percepiti come ambiti di rischio da circa un quarto delle aziende intervistate. Segnale che, accanto alle opportunità, cresce la consapevolezza delle responsabilità connesse.

Il collo di bottiglia delle competenze
Il vero nodo resta il capitale umano. Oggi in Italia solo il 27% della forza lavoro possiede competenze digitali avanzate, mentre il 44,1% delle posizioni aperte le richiede. Il divario - pari a oltre 4 milioni di lavoratori - si è ampliato di 630.000 unità in appena sei mesi. In parallelo, i percorsi formativi faticano a tenere il passo: i laureati STEM sono l'11,1% dei giovani contro una domanda di mercato che supera il 20%.
La ricerca mostra che il 67% delle imprese considera le competenze sull'IA ancora limitate e non adeguate a un'adozione efficace. Un gap che rischia di trasformarsi in ostacolo strutturale alla crescita, aggravando la storica stagnazione della produttività italiana.
Un aspetto interessante riguarda la diversa percezione tra le aziende: se nel 2023 oltre il 65% giudicava le competenze "poco diffuse", nel 2024 cresce la quota di chi le considera "abbastanza diffuse". Questo indica che alcune imprese iniziano a sviluppare percorsi interni di skilling e reskilling, ma la dinamica rimane minoritaria e insufficiente a colmare il divario sistemico.
I settori più promettenti
Il Rapporto individua i comparti con il maggiore potenziale trasformativo. La Pubblica Amministrazione, in cui l'IA può migliorare accessibilità ed efficienza dei servizi; i Servizi finanziari, dove l'automazione agentica può ridurre i costi di compliance e back office; l'Industria manifatturiera, che grazie a sistemi proattivi può ottimizzare supply chain e qualità; l'ICT, naturalmente, che diventa laboratorio di sviluppo e diffusione.
A questi si aggiungono l'energia e le utility, settore in cui l'IA agentica può gestire reti complesse in modo predittivo, e la logistica, dove l'autonomia decisionale degli agenti promette un salto nell'efficienza operativa. Si tratta di comparti che, oltre al peso economico, hanno valore strategico: la loro evoluzione determinerà la capacità del Paese di colmare il divario con le economie più avanzate.

Innovazione come obbligo, non scelta
La ricerca lancia un messaggio chiaro: l'innovazione non è più opzionale. L'IA Agentica rappresenta un salto di paradigma, dal supporto assistito all'automazione autonoma e proattiva. Le imprese che non adotteranno queste soluzioni rischiano di perdere rapidamente competitività in mercati sempre più integrati e automatizzati.
Per l'Italia, la vera sfida sarà duplice: da un lato potenziare la capacità di investimento e attrazione di capitali in un contesto internazionale dominato da Stati Uniti e Cina; dall'altro colmare il ritardo nelle competenze, senza le quali il potenziale economico rimarrà sulla carta. La transizione non sarà semplice: richiede politiche industriali mirate, incentivi alla formazione e un dialogo costante tra pubblico e privato.
Il Rapporto fotografa insomma una realtà ambivalente: la tecnologia è già pronta, ma le persone e i sistemi educativi non lo sono ancora. Il rischio è che l'Italia resti intrappolata in una modernizzazione a metà, incapace di trasformare la promessa dell'IA in produttività reale. Tuttavia, i margini di crescita stimati - fino a 336 miliardi di euro l'anno - offrono un'occasione storica. Colmare il divario di competenze, rafforzare la formazione e favorire una regolamentazione chiara e abilitante sono i passaggi imprescindibili per non perdere il treno dell'IA Agentica. Un treno che non aspetta: chi salirà per tempo guiderà la prossima fase di sviluppo economico.
ALTRI ARTICOLI
Banca
ABIServizi lancia Proposta 2026: competenze, strumenti e visione per governare la banca che cambia
Presentata al Congresso Assiom Forex di Venezia, la nuova offerta si rivolge agli Organi di vertice e alle alte professionalità del settore bancario...
Scenari
Oltre il credito: dove si sposta il valore nella relazione banca-cliente
Il 24 febbraio ABI inaugura a Roma il ciclo di incontri dei Comitati Tecnico Strategici che affrontano le tematiche più rilevanti dell’industria...
Scenari
Come affrontare la sfida di una “longevity society”
Quella mossa dagli over 55 è, già oggi, la terza economia del mondo. Ed è destinata a diventare dominante entro il 2050. L’Osservatorio D&I in...

L’appuntamento internazionale made in Italy sulle frontiere dell’innovazione nei pagamenti
Bancaforte TV

La decima edizione del Salone dei Pagamenti si chiude con un messaggio chiaro: l’innovazione nei pagamenti...

Nel mondo dei pagamenti digitali, le minacce non possono essere affrontate da un solo attore o da un singolo...