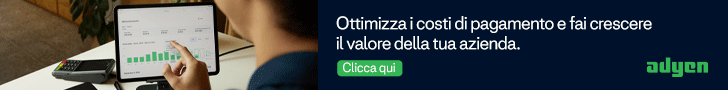20 Gennaio 2026 / 22:05
Trend topics
Imprese
Dal green all’inclusione: il marketing che racconta i valori aziendali
di Massimo Cerofolini
-
12 Novembre 2021
Ambiente e lotta alle diseguaglianze sono i pilastri dei messaggi con cui i brand mostrano i valori in cui credono e che sostengono. Una dinamica dove assume estrema importanza delle comunità dei consumatori, ma anche dei dipendenti e degli stessi Ceo. Ma occhio al green o al pink washing: è un attimo che ci si gioca la reputazione, specie coi più giovani! Un tema di strettissima attualità che ha animato il quarto incontro dell’Osservatorio Abi sulle nuove frontiere della comunicazione
La pandemia l’ha chiarito una volta per tutte. I consumatori, specie se giovani, più che un prodotto o un servizio oggi acquistano un’appartenenza, una visione del mondo in cui si riconoscono, uno stile di vita, una scelta di campo concreta e risoluta. Le imprese cominciano a capirlo. E adeguano la loro comunicazione al patrimonio di valori di cui dispongono, mettendo in risalto ciò che fanno sul fronte della sostenibilità, il loro impegno sociale verso chi è indietro o per le vittime del covid, la lotta alle diseguaglianze, sia fuori che dentro le mura aziendali. Ma come si racconta questo stile, questa sensibilità a ciò che conta nella vita? Come aggregare intorno a certe virtù comunità di persone in grado di portare contributi e far circolare velocemente i messaggi? Quali gli spunti utili per le banche? E, soprattutto, come evitare le bucce di banana, le scorciatoie, il green washing, in definitiva l’autogol? È da questa premessa che è partito il quarto incontro dell’Osservatorio digital marketing e comunicazione integrata di Abi, dal titolo “Farsi onore”, curato da Daniela Vitolo.
Tema del momento, non poteva essere altrimenti, la lotta al cambiamento climatico. Che diventa un tratto distintivo per promuovere il marchio. «Oggi – dichiara in apertura Fabio Iraldo, docente di Management alla Scuola superiore Sant’Anna e Direttore di Geo- The Green economy observatory dell’Università Bocconi – il consumatore è sempre più pronto a riconoscere l’impegno ambientale dei brand. Non siamo ancora al livello di domandare con forza servizi più green, ma certamente l’apprezzamento per scelte coerenti con la difesa della Terra ha un impatto molto forte sulla propensione all’acquisto. Mediamente, chi compra sa distinguere piuttosto bene una marca che si spaccia come verde da uno che lo è sul serio. Ed è forte anche la consapevolezza che, mettendo nel carrello un prodotto anziché un altro, ci assumiamo la responsabilità sulle sorti del pianeta. Le scelte che facciamo col nostro portafoglio hanno conseguenze nel futuro sulle sorti del clima. E ci stiamo attenti. Dieci anni fa non era così: i cambiamenti virtuosi si chiedevano alle aziende e alle istituzioni. Oggi li pretendiamo prima di tutto da noi stessi».
Da parte delle imprese, la metamorfosi è forse ancora più evidente: non sono più sul banco degli imputati come un tempo, come colpevoli di incentivare sprechi e consumi dannosi, ma siedono accanto a noi, come alleati, potenziali partner di battaglie ecologiste e sociali. «Questo – continua Iraldo – apre spazi di comunicazione molto efficaci, tanto più che con la pandemia la disponibilità del mercato a premiare l’offerta green è cresciuta. Un’azienda europea su quattro, per esempio, sottolinea nei suoi messaggi i comportamenti rispettosi dell’ambiente, anche a costo di intaccare quello spazio sacro del packaging riservato in genere a contenuti di altro tipo».
Il problema, però, nasce quando l’atteggiamento è soltanto di facciata, con il claim furbetto che nasconde il nulla. Una pratica piuttosto frequente, secondo Iraldo: «Abbiamo passato al vaglio 13 mila inserzioni pubblicitarie per vedere se erano in regola con le linee Iso: vale a dire chiarezza, accuratezza, comparabilità, rilevanza, affidabilità delle certificazioni e così via. Bene, 84 annunci sedicenti green su cento alla prova dei fatti lasciavano molto a desiderare».
E allora? Che fare? Prosegue Iraldo: «Per prima cosa evitare i peccati capitali, come l’uso di termini che occhieggiano al mondo di Greta, ma generici, privi di conferme scientifiche, con loghi luccicanti ma senza alcun valore, per non dire delle fake news e delle bufale. Al contrario, per essere convincenti, bisogna puntare su messaggi chiari, accurati, specifici e rilevanti. Meglio se accompagnati da certificazioni di parti terze. Tra l’altro sono in arrivo norme europee sulla tassonomia che indicano in modo specifico ciò che è davvero in linea con la sosteniblità. Molto efficaci sono poi gli inviti a comportamenti responsabili: penso a un noto shampoo che non solo informa su quanti progressi fa nel ridurre l’inquinamento, ma che stimola anche comportamenti ambientali, come l’uso corretto e moderato del prodotto».
Discorso analogo per l’altro grande ambito della riflessione: la diversità. Spiega Andrea Rubera, vice presidente di Liberi e Uguali e senior engagement manager di Tim, prima azienda di telecomunicazioni al mondo nella lista delle 100 più attente all’inclusione (Top 100 Diversity and inclusion index): «Se guardiamo ai grandi progressi della Storia, come l’Impero romano, gli Stati Uniti, il Rinascimento, la Belle Époque o la Silicon Valley, ci accorgiamo che il comune denominatore è sempre la coesistenza di diversità, anche laddove questa ha generato scontri. È infatti dall’incontro tra individui differenti che nasce qualcosa che avrà successo. I dati dimostrano che più cresce l’indice di tolleranza, più aumenta la capacità dell’impresa di attrarre talenti, di uscire dalla zona di conforto e innovare, di aumentare le prestazioni dei dipendenti, di migliorare il clima lavorativo interno, la relazione con il pubblico, i processi manageriali e la reputazione in generale. Ma benefici sono riscontrabili anche sulle prestazioni di Borsa e sul successo nei confronti della generazione Z, quella dei giovanissimi, molto attenta a queste tematiche».
Quattro le aree su cui Tim investe maggiormente per dare seguito alla sua promessa: l’età («è la prima volta nella storia dell’occupazione che lavorano insieme ben quattro generazioni, dai boomer agli Z»); la disabilità («non solo abbattiamo le barriere sia fisiche che mentali, ma concepiamo prodotti compatibili con le difficoltà personali, come l’assistenza tecnica dotata di un interprete del linguaggio dei segni»); il genere («G20 e Pnrr hanno come obiettivo la riduzione del divario tra uomini e donne, e noi italiani siamo fanalini di coda»); il mondo Lgbt («le nuove famiglie, il problema delle nuove identità e i nuovi modelli di coppia, da affrontare malgrado una legislazione poco favorevole»).
Anche qui non manca il pericolo di pink o inclusion washing, una verniciata di slogan buoni per la foto di rito e via, tutto come prima. Come evitarlo? «Per prima cosa – risponde Rubera – i bisogni da soddisfare devono emergere dal basso: sono le persone interessate a elaborare i progetti che poi noi metteremo in pratica. E poi è altrettanto importante valorizzare l’unicità della persona: non parliamo di categorie, ma di singoli individui, ciascuno con tante variabili, da ascoltare con cura e rispetto».
Una volta presi questi impegni il passo successivo è raccontarli. E un aiuto emergente viene dal brand journalism. «Il brand journalism – racconta Mariagrazia Villa, giornalista, autrice di un testo sul tema e docente di Etica e media allo Iusve – non è un contenuto per il marketing. Ma una forma di giornalismo che ha per editore l’azienda stessa, anziché un’impresa editoriale classica. Oggi ogni impresa è una potenziale media company e può produrre informazione coinvolgente a patto che questa risponda a criteri validi: deve essere interessante, notiziabile, rilevante e informativa». Le aziende possono ricorrere a diverse forme, sia analogiche (come brand magazine o libri bianchi) sia digitali (sito aziendale in ottica news, blog, radio o tv sul web, social network, app, ebook).
Tre poi i modelli su cui articolare l’offerta informativa. «Il primo – spiega Villa – è la brand news: l’azienda racconta il proprio mondo, le persone che lo compongono, la storia, le attività, gli aspetti distintivi dell’offerta, ma senza il proposito di vendere nulla. Il secondo riguarda la propria nicchia di mercato, in cui il brand journalism si dedica al settore mettendo in comune dati e previsioni collettive, ma anche parlando con lealtà di un concorrente. Il terzo, il più efficace, è quello che fa capo ai propri valori, dove la comunicazione punta su ciò che interessa al pubblico di riferimento, su temi non necessariamente connessi con l’attività della compagnia. Come nel caso di Red Bull».
Perché tutto sia credibile, sottolinea Villa, è necessario coinvolgere giornalisti veri, ricorrere a fonti certe e affidabili, godere di una certa libertà operativa rispetto al brand, avere quel gusto della notizia che si trova in una redazione tradizionale. Esempi di successo ce ne sono tanti: dalla storica Guida Michelin (nata nel 1900) al blog ecologista di Patagonia, passando per Fold di Moleskine sulla creatività o Macchine volanti di Tim sul futuro. “Ma l’esempio più convincente l’ha offerto HP, che nel proprio giornale ha ospitato giornalisti che criticavano i computer del brand”, sorride Villa. Feed back sui prodotti da una parte e apprezzamento per la sincerità e la trasparenza dall’altra.
A questo ruolo di portabandiera dei valori aziendali, sempre più spesso, contribuiscono anche gli amministratori delegati e i vertici del Cda. Dice Stefania Vitulli, coautrice di Ceo Branding nella reputation economy e docente di Corporate communication all’Università Cattolica di Milano: «Abbiamo esempi virtuosi di timonieri d’impresa che sulle scelte in cui credono ci mettono la faccia. A costo di sporcarsi le mani. Pensiamo a Riccardo Illy, che sottolinea l’importanza di un modello agricolo virtuoso. O a Brunello Cucinelli, che si presenta come esigente maestro e amabile padre, secondo cui il mondo ha bisogno di idealisti e di correttezza, perché devi sapere dove lavori e se il tuo lavoro arreca danni o no all’umanità».
Tre le caratteristiche distintive di un buon Ceo ambasciatore. Elenca Vitulli: «Può essere un sognatore, che comunica la promessa del brand per un mondo migliore. Può essere un attivista, capace di prendere posizione anche su temi scomodi. O può essere un idealista, che crede profondamente negli obiettivi etici perseguiti dall’azienda».
La pandemia ha alzato le aspettative dei consumatori, che non si accontentano più soltanto una dirigenza brava a gestire la complessità dei tempi moderni, ma che chiedono un tocco umano in grado di contraddistinguere la compagnia. «Anche se in passato non sono mancati gli scivoloni come le dichiarazioni anti gay di Barilla – osserva Vitulli – queste sono state subito recuperate con azioni di sostegno alle comunità Lgbt. E i dati dimostrano che – passate le proteste dell'inizio – schierarsi in modo deciso sui grandi temi alla lunga ha effetti positivi sul brand».
«Non dimentichiamo il caso di Nike – incalza Michele Mariani, direttore creativo esecutivo di Armando Testa Group – che ha avuto il coraggio di prendere le difese di Colin Kaepernick, il calciatore di football americano che non si era alzato durante l’inno statunitense per protesta contro i pestaggi della polizia ai danni dei neri. Dopo un iniziale boicottaggio da parte dei sostenitori di Trump e un conseguente crollo in Borsa, il titolo ha recuperato guadagnando oltre il 30 per cento, le vendite delle scarpe sono schizzate e la reputazione della multinazionale, soprattutto tra i giovani, è ora alle stelle. Come dimenticare lo slogan della campagna? Non chiedere se i tuoi sogni sono folli, chiedi se sono folli abbastanza».
Anche gli stessi dipendenti dell’azienda possono aggregarsi in comunità capaci di raccontare i valori del brand in modo efficace e convincente. Luigi Centenario insegna Personal branding e innovazione professionale alla Sda Bocconi: «È interesse dell’impresa – sostiene - coinvolgere le persone che lavorano con lei in progetti di comunicazione, specie sui temi della sostenibilità o dell’inclusione. I singoli lavoratori hanno i loro desideri e possono diventare dei media in grado di raccontare l’azienda mentre esprimono i propri valori. Se comunico qualcosa in cui io e la mia società crediamo, posso ispirare e unire persone che vogliono partecipare alla mia causa. E questo si traduce in una crescita fortissima sulla reputazione aziendale. Marchi come Ibm, Microsoft o Activia investono molto nella creazione di ecosistemi di comunicazione per brand ambassador».
È così che un marchio diventa una calamita capace di associare persone che intorno a quei valori scoprono intese, fratellanze e voglia di mettersi in gioco. Marta Mainieri, ceo e fondatrice di Collaboriamo, oltre che autrice di Community economy, ha le idee chiare: «La community a cui le società moderne devono tendere non è il pubblico, neppure nel senso in cui lo si intendeva negli anni Duemila, come gruppo di clienti intorno a un prodotto. La community oggi è un gruppo di persone che condivide proposte di valore, che riguardano un progetto, un territorio o un’offerta commerciale molto ben pensata. Persone che hanno piacere di fare qualcosa insieme, sotto lo stimolo del brand che assicura un ambiente favorevole allo sviluppo delle iniziative».
I casi possono essere diversi. A volte nasce prima la comunità intorno a un interesse o a un problema collettivo e poi col tempo arrivano i servizi valutabili economicamente e ci si struttura in impresa. Altre invece sono le aziende stesse a intercettare i valori che germogliano spontaneamente sul web o nella vita reale: pensiamo a Lego Ideas, che conta un milione e mezzo di persone che generano decine di migliaia di proposte tra cui il brand sceglie quelle da sviluppare. «Ovviamente – continua Mainieri – non sono cose che si improvvisano. Occorre stabilire l’identità, in termini di valori, attori e narrazione, le modalità di ingaggio e i canali su cui veicolare l’offerta da progettare, la governance e i ruoli all’interno della comunità. Ecco, la creazione della community deve essere strutturata mettendo al centro non le persone ma il gruppo, perché il valore vero arriva quando sono le persone a costruirlo con il loro entusiasmo e la disponibilità a darsi da fare insieme agli altri. E quando questo succede l’azienda ha fatto centro».
ALTRI ARTICOLI
Credito
Klarna accelera con P2P istantaneo, carte e pagamenti alla PA
Il lancio dei trasferimenti tra privati si inserisce in una fase di forte espansione funzionale della piattaforma, che sta progressivamente coprendo...
Fintech
Fintech, un miliardo di investimenti e l’AI al centro della trasformazione bancaria
L’Indagine Fintech 2025 della Banca d’Italia racconta un’innovazione che smette di essere sperimentazione e diventa leva industriale. Le...
Credito
Con Finomnia il Gruppo Fibonacci mette a sistema l’innovazione
Il nuovo brand consolida le diverse expertise del Gruppo, per continuare a essere catalizzatore della trasformazione digitale nelle aree più...

L’appuntamento internazionale made in Italy sulle frontiere dell’innovazione nei pagamenti
Bancaforte TV

La decima edizione del Salone dei Pagamenti si chiude con un messaggio chiaro: l’innovazione nei pagamenti...

Nel mondo dei pagamenti digitali, le minacce non possono essere affrontate da un solo attore o da un singolo...