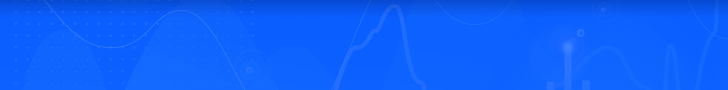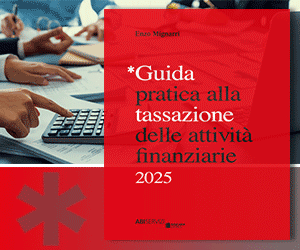25 Aprile 2025 / 04:18
Trend topics
Fintech
Data journalism: il giornalismo nell’epoca dei Big Data
di Mattia, Schieppati
-
5 Dicembre 2014
Sul modello anglosassone, anche i media italiani cominciano ad avvicinarsi in maniera scientifica all’uso di infografiche per raccontare l’attualità. È il punto di incontro tra informazione e tecnologie digitali ...
Non si tratta di macchie colorate pensate per abbellire le pagine di giornali e riviste. Ma potremmo considerarla una conseguenza della diffusione sempre più pervasiva dei “big data” e della necessità di razionalizzarli, interpretarli, divulgarli e renderli comprensibili a tutti. Ecco perché nell’era del digitale e dell’accesso sempre più facile e immediato a informazioni e banche dati, si sta sviluppando in tutto il mondo in maniera molto accelerata il “data journalism”, ovvero il giornalismo di informazione che utilizza numeri, grafici, tabelle, torte e elaborazioni infografiche per raccontare fatti e scenari d’attualità.
Come l’ha definito Antonio Troiano, responsabile dell'inserto La Lettura del Corriere della Sera, che già due anni fa ha cominciato a dedicare una doppia pagina a questa forma di nuova informazione, «è la capacità di elaborare l'immensa moltitudine dei dati che la rete ci offre, grezzi e ambigui, per manipolarli attraverso le tecnologie digitali in informazione visiva. Non un articolo di giornale, non un saggio, non un servizio televisivo o radiofonico. Ma un quadro. Il più possibile bello da vedere e chiaro da comprendere».
 Esempio di infografica della “La Lettura” del Corriere della Sera
Esempio di infografica della “La Lettura” del Corriere della Sera«Internet e la diffusione dei dati digitali hanno creato nuove opportunità. Oggi il mondo produce così tanti dati, e i computer possono analizzarli così in fretta, che il giornalismo basato sui dati merita di occupare una grande parte del ciclo informativo quotidiano. Una delle nostre priorità è portare alla luce i dati - e analizzare quelli già esistenti - con modalità che illuminino e spieghino la notizia», spiega infatti David Leonhardt, responsabile di The Upshot, la sezione del New York Times basata sul data journalism (clicca qui). Da modelli di data journalism più di nicchia, come quello del sito di informazione FiveThirtyEight fino alle grandi strutture come quelle del Guardian, uno dei pionieri in questo tipo di nuova informazione i modelli non mancano.
 La mappa della metropolita londinese: la stilizzazione proposta da H.C. Beck è diventata per la sua leggibilità e chiarezza un modello per tutte le mappe dei trasporti del mondo
La mappa della metropolita londinese: la stilizzazione proposta da H.C. Beck è diventata per la sua leggibilità e chiarezza un modello per tutte le mappe dei trasporti del mondoIl mondo dell’informazione italiana, su questo fronte, è ancora un po’ in ritardo: il concepire ormai il giornalismo solo come grandi articolesse fitte di parole e di concetti che ingarbugliano la realtà anziché spiegarla con chiarezza al lettore certo non aiuta. Ma qualche buon esempio c’è. Il Corriere della Sera questo “esempio” l’ha portato addirittura in mostra, alla Triennale di Milano, dove in occasione di BookCity e fino al 14 dicembre è allestita una mostra - Le mappe del sapere- che racconta l’impegno nell’infografica e nel data journalism su cui ha scommesso l’inserto culturale La Lettura: presentazioni grafiche di correlazioni numeriche potenzialmente infinite che, in modo inedito ed esteticamente affascinante, raccontano storie o personaggi, propongono tesi o suggeriscono ipotesi. Narrazioni che si esprimono principalmente attraverso il linguaggio visuale permettendo al lettore di immergersi in argomenti sempre diversi: dai testi di Kant alle cover musicali, dai colori dei quadri di Pollock a quelli della moda; dai Nobel ai Simpson. Un modo non dogmatico di fare informazione, punto d’incontro tra creatività e razionalità dei codici di scrittura, espressione di questo nuovo modo di fare giornalismo.

 Due esempi di infografiche utilizzate rispettivamente da The Guardian e The New York Times
Due esempi di infografiche utilizzate rispettivamente da The Guardian e The New York Times«È un giornalismo per smanettoni?», si chiedono gli esperti di Fondazione <ahref, uno dei più avanzati think-tank italiani sugli orizzonti digitali. «No, è un giornalismo che chiede di rispettare tutti i vecchi crismi (ipotesi, ricerca e verifica e ovviamente anche olio di gomito…), ma si avvantaggia di software, per mettere in relazione le masse di dati rese disponibili dalla digitalizzazione, ma spesso prive di senso se non le si affronta con strumenti abbastanza potenti.
In Italia non ci sono, purtroppo, repository di dati pubblici altrettanto ricchi come il data.gov statunitense e il data.gov.uk britannico e le norme che garantiscono l’accesso ai dati pubblici come le legge n. 241 del 1990 e i suoi aggiornamenti sono ancora molto lontane da ciò che garantisce il diritto a Londra e a Washington». Ma, osservano i ricercatori, «in uno scenario nel quale la digitalizzazione dei dati è ancora troppo spesso percepita come un vulnus ai media l’utilizzo e la creazione di dati open source, si profila come una grande occasione sia per l’informazione che per la democrazia perché, oltre a creare nuovi strumenti di lavoro per i giornalisti, sta spingendo a nuove dinamiche collaborative con e tra i lettori, aumentando il coinvolgimento della società civile e la trasparenza delle fonti».
ALTRI ARTICOLI
Imprese
Tanzi (Quid Informatica): Pronti ad accompagnare il mondo del credito nelle sfide cloud e SaaS
La recente integrazione nel gruppo Fibonacci ha rafforzato la tech company come punto di riferimento tecnologico per il consumer finance in Italia,...
Banca
Formazione e apprendimento in Europa, tutti i partner di EBTN presenti a Milano
Dal 12 al 14 marzo presso SpazioPola, il centro di ABIFormazione a Milano, si sono tenuti gli incontri di EBTN – European Banking and Financial...

L’appuntamento di riferimento sui Pagamenti e l’Innovazione in Italia e non solo.
Bancaforte TV

La PSD2 non ha fatto esplodere l’open banking in Italia ma ha piantato i semi di unaevoluzione da cui non si...